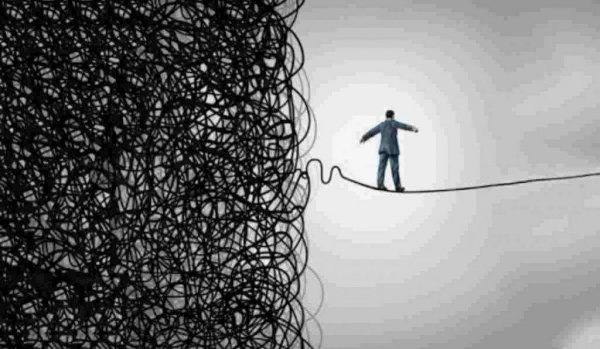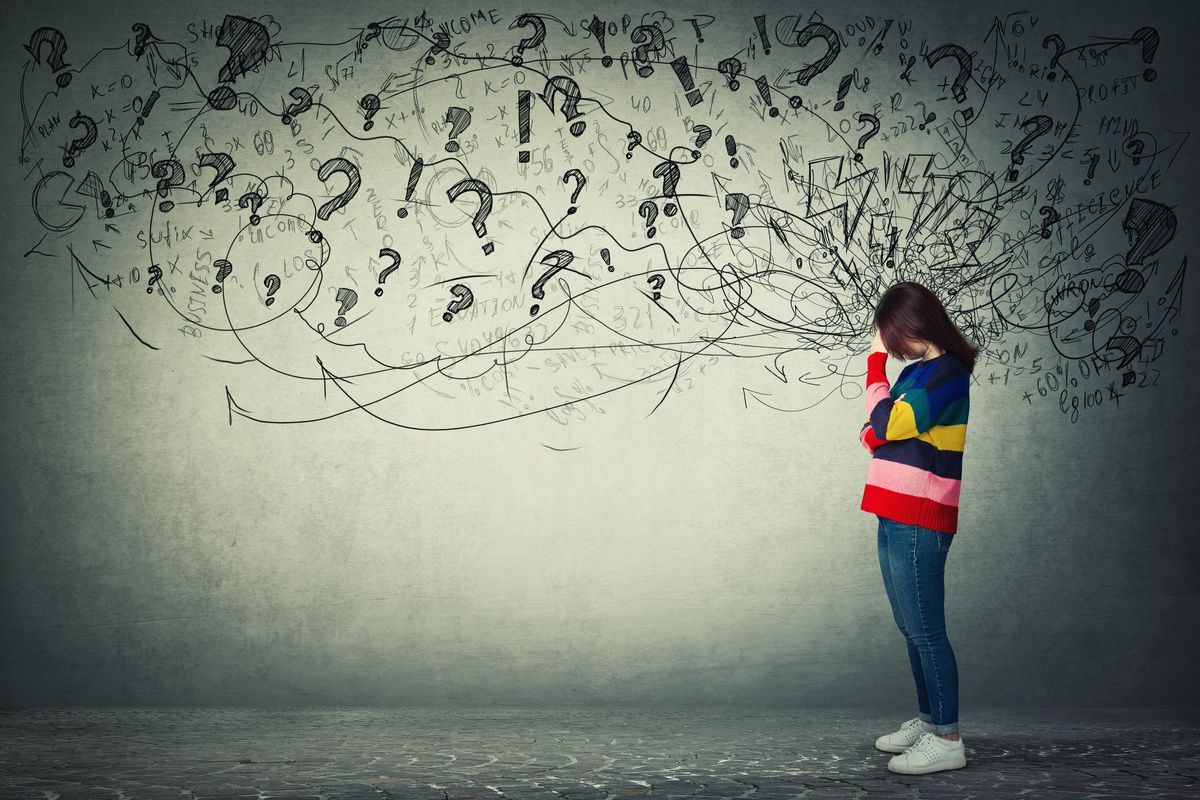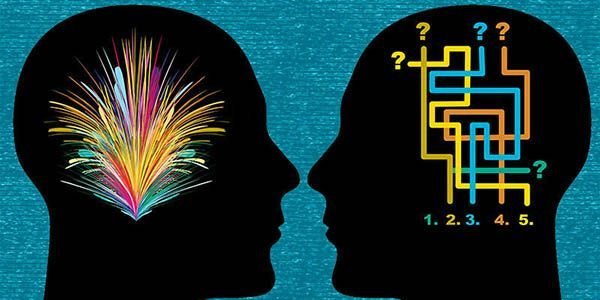
Il disturbo ossessivo-compulsivo è caratterizzato dalla presenza di ossessioni, ovvero da pensieri, impulsi o immagini ricorrenti che irrompono nel funzionamento mentale e che agiscono in modo automatico. La persona si sente sopraffatta, piena ed incapace di mettere a tacere le proprie ossessioni avvertendo un forte senso di stanchezza, oltre a fare molta fatica nel prestare attenzione, ed essere presente quando la mente è occupata da questi pensieri ricorrenti. Le compulsioni, invece, sono delle azioni osservabili, attività mentali o comportamenti ripetitivi che il paziente esperisce come obbligatori. Questi comportamenti ripetitivi possono diventare sempre più rigidi. La persona può sentirsi costretta a mettere in atto, non solo singole azioni o attività mentali, ma anche a farlo con una sequenza rigidamente organizzata (rituali compulsivi). Gli stati affetti che accompagnano il disturbo ossessivo compulsivo sono depressivi, soprattutto quando vi è una buona capacità d'insight in quanto la persona può riconoscere la stranezza e l'incongruenza delle sue idee ma, nonostante ciò, non può fare a meno di subire questi pensieri e compulsioni. La persona si deprime perchè sente di non riuscire a non farsi influenzare, a smettere di alimentare idee che non reputa adeguate. Le ossessioni e compulsioni causano un disagio personale e sociale, infatti lo stare insieme agli altri può risultare molto complesso, dispendioso ed è impossibile riuscire a nascondere sempre le proprie compulsioni. Per questo motivo, alcune volte l'individuo preferisce isolarsi ed evitare il contatto con gli altri pur di non sostenere tutta questa fatica. Allo stesso tempo, se non si riesce a mettere in atto i propri rituali e compulsioni si sperimentano emozioni di paura, irritabilità o aggressività. Secondo il PDM-2, gli stati somatici che contraddistinguono il seguente disturbo sono di ansia, irrequietezza, affaticabilità e vi possono essere anche tic di natura motoria. Alla base del disturbo vi è una rappresentazione mentale, idea, che viene slegata dal suo affetto e visto che non vi è l'azione della rimozione, come magari può accadere nell'isteria ad esempio, l'affetto mantiene tutto il suo potere originario; non c'è nulla che smorza la sua potenza. L'affetto, che vaga liberamente nello spazio psichico, viene legata ad un altra rappresentazione, più accettabile rispetto a quella originaria, generando un falso nesso, ovvero una rappresentazione ossessiva. La persona non riesce a liberarsi da questo oggetto, idea ossessiva perchè è il mantenimento dell'oggetto che garantisce la sicurezza dell'io. Il mantenere l'oggetto in una fluttuazione tra impossessamento e padronanza consente di dirottare, verso l'oggetto (esterno) la quota di pulsione di morte che, nella melanconia, viene dirottata contro l'Io. La rappresentazione originaria resta, anzi grazie all'intervento della condensazione (una cosa ne riassume tante altre in modo inconsapevole) e spostamento può accedere liberamente alla coscienza in quanto non incontra più la censura. La rappresentazione, essendo stata scissa dal suo affetto originario, non risulterà più inaccettabile per il Super-Io. È questo il motivo per cui l'ossessivo sa tutto, ricorda ogni cosa nel minimo dettaglio poichè le rappresentazioni mentali sono state spogliate dell'elemento più pericoloso: la reazione affettiva. Potremmo dire che l'ossessivo sa tutto perchè non sente, non prova nulla, per lui sono solo dettagli concreti e razionali. I meccanismi difensivi che vengono usati nel disturbo ossessivo-compulsivo sono l'isolamento (i contenuti mentali vengono slegati dagli affetti), l'annullamento retroattivo (fare qualcosa per rendere non avvenuto qualcos'altro), spostamento e formazione reattiva (esprimere contenuti opposti a quelli avvertiti), rivolgimento nel contrario, razionalizzazione (fornire spiegazioni razionali) ed intellettualizzazione (astrazione delle emozioni per non sentirle). Tutte queste manovre difensive sono accomunate da un iper investimento sul pensiero razionale che nasce dalla costante "paura d'impazzire", ovvero di perdere il controllo e di essere sommersi dagli affetti. Il controllo viene esercitato per tenere a bada questa paura d'impazzire e strettamente correlato a questo meccanismo vi ritroviamo il perfezionismo, il quale è espressione di un tentativo di controllo della realtà esterna ed interna. Gli ossessivi pensano sempre, dichiarano di essere stanchi e di sentirsi pieni, vorrebbero "staccare" il loro cervello. Il problema non è legato al pensiero, ma alla qualità del loro pensare. L'azione massiccia dell'isolamento è incompatibile con il pensiero simbolico, creativo che si fondano sul potere semantico ed evocativo della parola. L'isolamento tende alla dissoluzione di una qualsiasi forma di legame, per questo motivo il pensiero simbolico non può essere accettato, è pericoloso perchè rischierebbe di creare e svelare legami che si vogliono scindere. Nel pensiero ossessivo, visto che prevale la tendenza a scindere, la sublimazione e creatività vengono sostituiti dalla logica e razionalità. Questo tipo di pensiero è stancante, non porta da nessuna parte perchè non è vitale, è spogliato della sua componente principale: gli affetti. L'attacco ai legame, riprendendo la teoria di Bion, non permettono la formulazione di un pensiero creativo che si alimenta di legami, non solo con gli affetti ma anche con altre idee. La logica ossessiva è abitata dal dubbio, dalla concentrazione sui dettagli che serve, non solo ad impedire una consapevolezza diretta verso le componenti libidiche e aggressive, ma ci dicono anche di un erotizzazione del pensiero, così come fu evidenziato da Freud (1909). Nello specifico, vi è un piacere diretto verso l'atto del pensiero in se, anzichè al suo contenuto. Nella funzione anale dello sviluppo libidico, il pensiero e l'azione sembrano essere ancora indifferenziati. La fissazione alla fase anale dell'ossessivo ci permette di capire come il pensiero può sostituirsi all'azione e l'azione al pensiero. Per l'ossessivo, pensare equivale ad agire ed agire di averlo pensato. Un'altra caratteristica della logica ossessivo è il pensiero magico che viene utilizzato per eliminare, attraverso l'annullamento retroattivo, un pezzo di realtà indesiderata. Questa azione provoca una distorsione della realtà stessa che, però, non è una cancellazione o diniego testimoniando la presenza di una scissione tra una parte onnipotente ed un'altra legata al principio di realtà; infatti la persona è in grado di riconosce l'assurdità del suo pensiero. L'ossessivo sperimenta, dunque, contemporaneamente l'onnipotenza del pensiero e la sua impotenza in quanto lo subisce attraverso le ossessioni, i dubbi e le superstizioni da cui cerca di sfuggire con l'illusione del controllo onnipotente. Ma dove nasce questa impossibilità di metabolizzare? Perchè l'affetto viene scisso ed isolato? Un difetto di funzionamento della reverie conduce alla formazione di un Super-Io rigido e controllante che non consente di metabolizzare le protoemozioni, questi affetti arcaici e grezzi. L'incapacità di metabolizzare gli elementi beta, trasformandoli in elementi alfa, crea una situazione potenzialmente angosciante, un "troppo pieno". Uno dei modi con cui la nostra psiche potrebbe cercare di sopperire a questa angoscia è dato dall'uso dei meccanismi ossessivi. Come affermava Freud, il sintomo rappresenta la soluzione migliore che la nostra mente è in grado di trovare nel momento in cui la mette in atto.
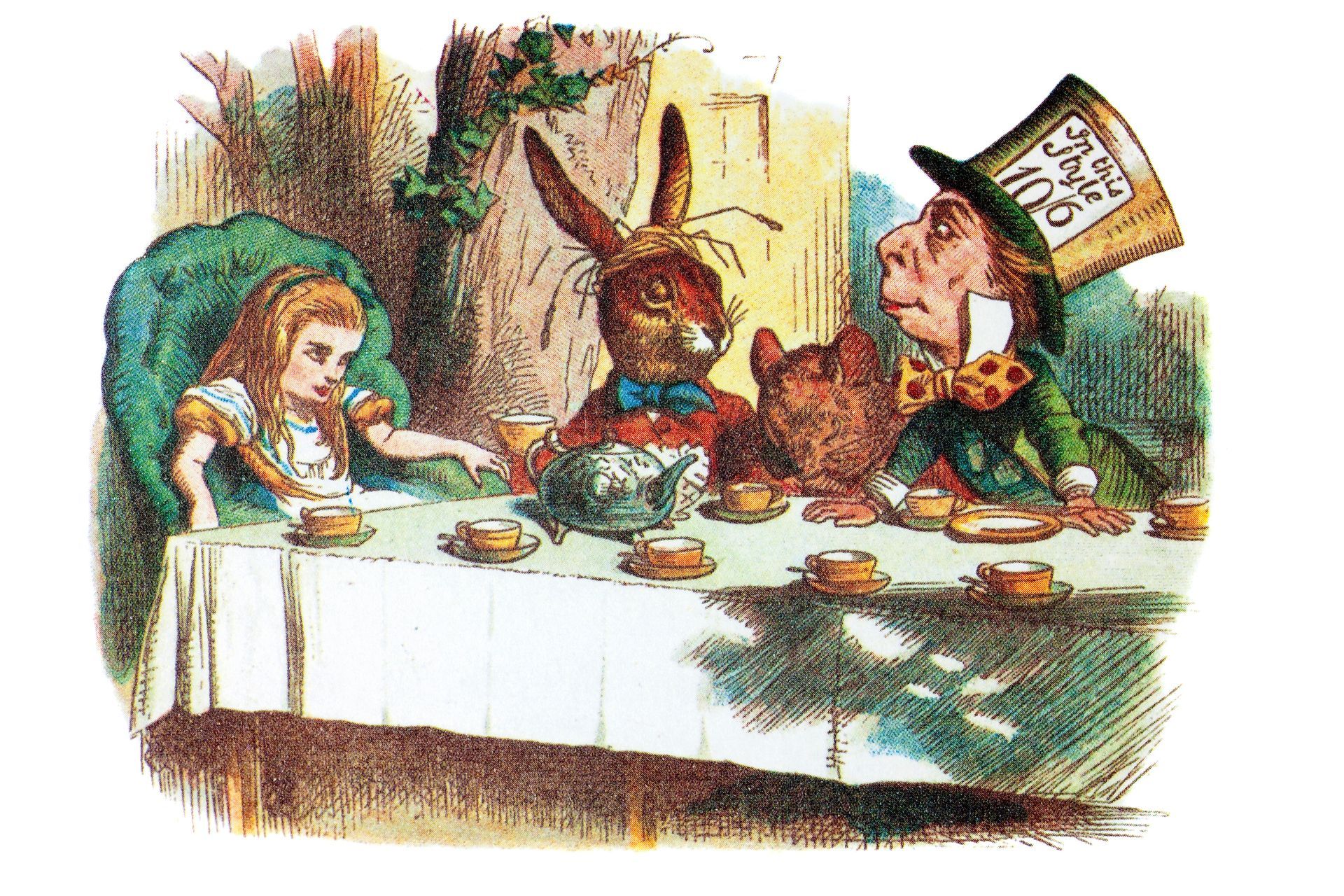
Il film “Alice attraverso lo specchio” sembra rappresentare una continuazione del precedente in quanto la protagonista è alla prese con tematiche adolescenziali e sullo sfondo resta vivo il mondo fantastico infantile che aveva caratterizzato “Alice nel paese delle meraviglie”. Il titolo del film ci potrebbe fornire una prima riflessione importante, riprendendo il pensiero winnicottiano, cosa vede Alice attraverso lo specchio? Dalle prime scene del film emerge una “ragazzina” spavalda, che affronta la tempesta credendo che “l’impossibile sia possibile”. La sua onnipotenza la conduce a compiere una manovra avventata per superare i suoi inseguitori quasi come se si divertisse a sfidare la morte avvicinandosi al pericolo. È solo un taglio della vela, compiuto nel secondo giusto, che le permette di sfiorare la roccia senza toccarla. Alice sembra essere alle prese con i suoi oggetti interni in quanto la nave era di proprietà del padre e lei si scontra con la madre sentendola lontana e diversa da Se. La protagonista vorrebbe essere suo padre e la rivalità con la figura materna non le permetterebbe di identificarsi con la madre avvertita come pericolosa, come i “pirati dal quale fuggire”. Questa situazione avrebbe delle ripercussioni sulla sua femminilità e per questo Alice si lancia nello specchio per vedere cosa c’è dentro, in quanto l’immagine riflessa sembra essere instabile così come potrebbe essere la sua identità di donna. Nel suo viaggio la protagonista riscopre il suo mondo fantastico infantile indebolito ed intaccato dalla morte, il tempo ovvero dai limiti della realtà. Il suo primo tentativo è quello di ripristinare lo stato delle cose, di riportare tutto com’era prima. Aiutare il cappellaio matto a riportare in vita la sua famiglia sembra essere un tentativo disperato di ritornare ad essere il bambino del suo nucleo familiare che ha un conto da saldare, chiedere scusa al padre. A questo punto compare il terzo, il nome del padre ovvero il tempo, il limite che gli ricorda “di non essere un ladro, che il passato non può essere cambiato, che possiamo solo imparare dal nostro agire passato”. Alice prova a sfidare il tempo, è convinta di poterlo cambiare e quando ci prova fallisce incominciando ad intuire che l’impossibile non può esser possibile, facendo esperienza di un limite che non può più essere sfiorato come era successo con le rocce nella tempesta. A questo punto viene fatta una scoperta molto importante, significativa per il processo di crescita di Alice. Il passato non può essere cambiato, ma, lo si può guardare da un punto di vista diverso. La protagonista scopre che i genitori del cappellaio matto erano ancora vivi ed erano stati rapiti dalla strega cattiva, la figura materna preedipica. Alice passa dall’azione, il voler cambiare le cose concretamente, all’osservare gli avvenimenti. Questa situazione sembra sovrapponibile alla magia che si realizza nella stanza d’analisi, quando gli agiti lasciano il posto al pensiero, alla conoscenza dell’inconscio. Sullo sfondo compare anche la rivalità fra fratelli, infatti, ricostruendo la storia si umanizza la regina la quale era mossa dal rancore per la bugia raccontata dalla sorella alla madre. Il ricevere le scuse era l’unica cosa che la regina di cuori avrebbe voluto ascoltare in quanto esse rappresenterebbero una legittimazione della sua rabbia, un riconoscimento della sua soggettività, del suo essere umano. Al suo dolore viene dato parola, trova una spiegazione permettendo alla donna di comprenderne l’origine e, dunque, il significato. Le scene conclusive del film sono molto significative e toccanti in quanto mostrando un Alice diversa, più donna che ragazzina spavalda la quale si riappacifica con il tempo aiutandolo a rimediare ai danni causati dal suo agire. Mostra di aver capito, adesso, il suo avvertimento sull’impossibilità di cambiare il tempo ringraziandolo, quasi, di essere stato sempre presente non mollando mai la presa su di lei. Nel salutare gli oggetti magici del mondo infantile, Alice chiede giustamente al cappellaio matto dove finirà tutto ciò che ha vissuto. Il cappellaio ci ricorda come le tracce della nostra infanzia restando dentro di noi, come in ogni adulto c’è sempre il bambino/a che siamo stati. Alice recupera anche la sua identificazione materna, adesso le due donne sembrano essersi riappacificate in quanto la protagonista si è costituita una sua identità la quale viene accetta e rispettata dal suo genitore. Ci potremmo richiedere, adesso, cosa vedrà Alice quando si guarderà allo specchio?
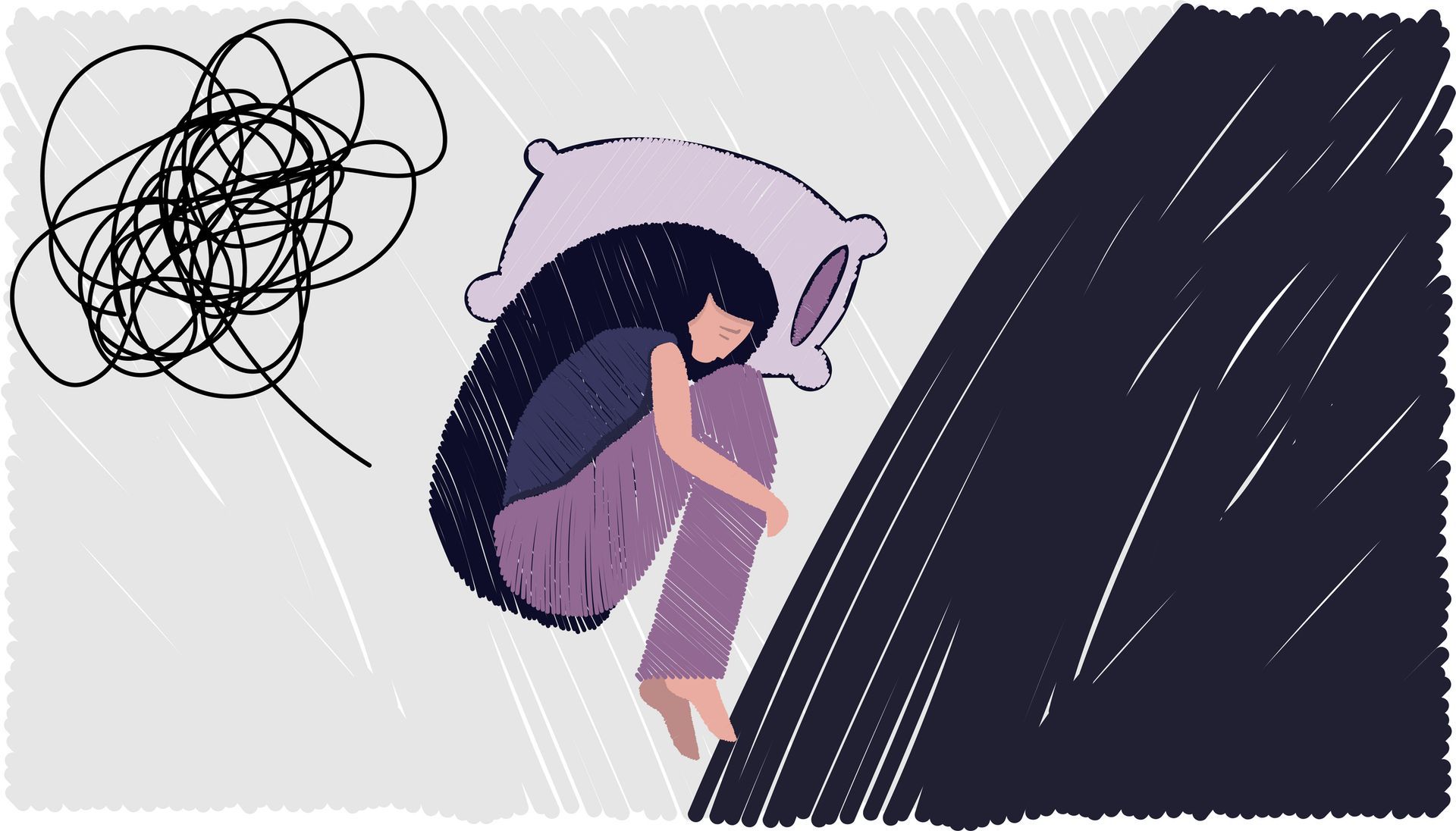
Oggi giorno la riabilitazione accoglie bambini e ragazzi con diverse diagnosi, dal neuro sviluppo ai disturbi dell’apprendimento passando per quelli appartenenti alla salute mentale e neurologici. La realtà clinica è sempre più complessa di quella accademica, teorica per questo ci sono moltissimi casi di doppia diagnosi, ovvero quadri clinici dove convergono più di una diagnosi. Ci sono altre situazione dove un quadro diagnostico principale può portare, come conseguenza, ad altre problematiche. Un esempio potrebbe essere caratterizzato dalla presenza di un umore depresso in conseguenza ad un disturbo dell’apprendimento. Questa prima considerazione basterebbe per affermare che non può esistere una riabilitazione in assenza di una terapia psicoterapica. La psicoterapia infantile ha gli stessi obiettivi di quella per adulti solo che segue indicazioni, protocolli ed approcci adeguati all’età infantile. Per questo motivo, i quadri diagnostici del neuro sviluppo e di salute mentale sono strettamente e direttamente pertinenti al lavoro psicoterapico che si può avvalere della collaborazione di altre figure professionali in un ottica multidisciplinare. In aggiunta, ci sono gli interventi che potremmo definire “indiretti”, ovvero quelle situazioni neurologiche dove c’è la necessità di lavorare su aree specifiche quali l’accettazione e la consapevolezza della diagnosi, attivare le risorse interne, imparare a convivere con la diagnosi, capire come potersi porre al mondo esterno, supportare la famiglia… Per quanto concerne gli apprendimenti, “l’apprendimento è mediato dalle emozioni e dagli affetti individuali, dunque è difficile pensare di favorire un processo di apprendimento solo attraverso dinamiche cognitive e socioculturali perché non è un processo del tutto meccanico, ma dipende fortemente dalla qualità emotivo-affettiva dell’incontro con l’altro” (Verschueren, Koomen, 2012). L’importanza della sfera emotiva e relazionale nei processi d’apprendimento giustifica la scelta di un trattamento multidisciplinare che vede la collaborazione tra la logopedia e la psicoterapia o il supporto psicologico. Molto banalmente, se un bambino è preoccupato o agitato per qualcosa l’apprendimento rappresenterà l’ultimo dei suoi pensieri, così come fornire strumenti compensatori potrebbe risultare inutile se, ad esempio, i ragazzi si rifiutano di usarli perché magari si vergognano. “Gli studi sostengono che lo sviluppo socio-emotivo può contribuire in modo significativo allo sviluppo cognitivo influenzando l’acquisizione del linguaggio, le capacità di attenzione e apprendimento” (Commodari, 2013). Considerando che tra le componenti cognitive ed emotive esistono delle correlazioni bidirezionali, ovvero l’uno incide sull’altro e viceversa, è impensabile immaginare che un paziente possa accedere alla riabilitazione senza mai sentire la necessità di aver bisogno di una psicoterapia o un supporto psicologico. I piani riabilitativi dove non viene mai prevista una prestazione psicologica o psicoterapica sono destinata ad essere limitati o fallimentari, nel raggiungimento degli obiettivi prefissati, perché nel trattamento viene esclusa la sfera emotiva, relazionale e di supporto alla famiglia. D’altronde, come si può pensare di accedere alla riabilitazione senza mai avere dubbi, incertezze, preoccupazioni, perplessità, provare frustrazione e rabbia, sentirsi diverso e a disagio con gli altri, mostrare incertezza per il proprio futuro…? In aggiunta a quanto detto, bisogna anche considerare l’aspetto della salute mentale degli altri terapisti impegnati nella riabilitazione quali i logopedisti, i terapisti occupazionali, gli educatori ed i psicomotricisti. Il lavoro riabilitativo è a forte rischio di burn out perché i lavoratori entrano costantemente in contatto con dinamiche personali assorbenti, con il dolore e la sofferenze delle persone. I terapisti si possono trovano a dover fronteggiare sentimenti quali la frustrazione, l’impotenza di fronte ad alcune patologie molto invalidanti. Per questo motivo, non si può immaginare una riabilitazione sprovvista della psicologia e psicoterapia.

Nel secolo scorso il “medico di famiglia” era colui che si prendeva cura delle famiglie di una specifica circoscrizione geografica. Il suo era un intervento a 360 gradi, nel senso che veniva contattato per la risoluzione delle problematiche più disparate ed era a conoscenza della storia personale e familiare di ogni singolo paziente, inclusi i suoi segreti più inconfessabili. Le nuove scoperte mediche realizzate negli ultimi decenni e la nascita della psicologia ci hanno permesso di avere una visione sempre più complessa del funzionamento umano. Questo risultato è stato ottenuto con la nascita di un sapere sempre più specializzato, settoriale che ha permesso la formazione di diverse branchie fra cui la neurologia, psichiatria, ortopedia, ginecologia e via dicendo. Se da un lato questa strada intrapresa ha permesso il raggiungimento di risultati molto importanti, dall’altro canto potrebbe indurre nell’errore di acquisire una visione “frammentata” dell’individuo il quale non viene più visto come una persona, ma, come un “organo”, “un idea” da curare. La persona si trasforma, così, nella gamba che fa male, nel mal di testa, nell’ansia, lo stress, ecc. Sembra assistere sempre più alla diffusione di una falsa credenza secondo cui il corpo e la mente sarebbero due entità separate, due “vicini scontrosi” che non si parlano ignorandosi a vicenda. Bisogna considerare che la divisione mente-corpo è un esigenza puramente teorica e che non riflette il funzionamento reale. Come si fa a distinguere dove inizia la mente e dove finisce il corpo? D’altronde la mente non è essa stessa corpo? Proviamo a pensare alle situazioni quali la presenza di stati ansiosi, attacchi di panico, stress e l’ipocondria. In questi casi l’individuo pone la sua attenzione solo sul corpo, sul sintomo o sulla sensazione corporea che gli arreca preoccupazione e fastidio. La persona si ritrova a fare una “caccia alle streghe”, ovvero si prende cura dell’organo sofferente senza mai giungere ad una soluzione poiché, inconsciamente, affronta il problema da un punto di vista sbagliato. La scorrettezza delle sue azioni, le quali tendono a sfinire il soggetto demoralizzandolo per via degli scarsi risultati ottenuti, derivano dal confondere la causa del malessere con la sua manifestazione. La sofferenza del corpo serve a dire “eh, ascoltami, qui c’è qualcosa che non va!” e nel caso in cui si prova solo a tamponare questo dolore, attraverso l’assunzione costante di farmaci, si realizza un’incomprensione che darà vite a comunicazioni successive sempre più intense e anche di natura differente. Il dolore fisico può anche essere spostato, passare da un organo all’altro, in quanto il nucleo del messaggio resta sempre lo stesso: la richiesta d’aiuto. Vi è un corpo che soffre perché la mente non è stata in grado di farsene carico e, per questo, prova a liberarsene attraverso il dolore fisico. Questo passaggio è molto importante e per questo non va frainteso, nel senso che non bisogna ignorare la cura del copro pensando che “tutto dipenda dalla mente”, poichè il corpo e la mente sono un tutt’uno, un’unica unità, due facce di una stessa medaglia. Noi siamo portati, in modo automatico, a dare senso a tutto ciò che ci circonda compresi gli stimoli corporei ed il significato attribuito ad una malattia, ad esempio, sarà sempre una questione soggettiva in quanto sarà influenzato dalla nostra storia personale e da vissuti emotivi già sperimentati. Quanto detto viene supportato dalle ricerche scientifiche le quali hanno dimostrato, ad esempio, che l’attività del nostro sistema immunitario è influenzata dall’umore, che la psicoterapia influenza l’assetto neuronale portando alla formazione di nuove sinapsi, della presenza di cellule neuronali nello stomaco. D’altronde la stessa esperienza del dolore è soggettiva, ad esempio la nostra mente può interpretare erroneamente degli impulsi confondendoli con quelli del dolore. Tutte queste considerazioni ci fanno riflettere sulla complessità del nostro funzionamento e su come, a prescindere da quale che sia la causa primaria, la sofferenza localizzata nel corpo o nella mente non è mai una questione che riguarda solo “l’uno o l’altro” a causa delle continue comunicazioni ed influenze reciproche, come recita un famoso detto “mens sana in corpore sano” (mente sana in un corpo sano). Queste considerazioni del funzionamento umano ci dovrebbero far riflettere sul rapporto professionale tra i diversi professionisti che si occupano della cura della persona. L’integrazione, una visione più realistica del funzionamento umano richiederebbe una stretta collaborazione tra le diverse professioni sanitarie (infermieri, ostetrici, medici, psicoterapeuti, biologi, chimici). Ma come si fa a collaborare con persone che seguono logiche di potere o di lobby? Intraprendere una lotta di potere, dimostrare di essere la disciplina più importante o seria ha come unico obiettivo l’arricchimento economico, narcisistico del professionista a discapito del benessere della persona. Ci sono medici che “non credono nella psicoterapia oppure considerano i pensieri come un qualcosa di astratto” così come ci sono psicoterapeuti che ignora l’importanza e l’impatto del corpo. Come possono essere astratti i nostri pensieri se guidano, sono alla base di tutte le nostre scelte e progetti di vita presenti e futuri? Non esiste nulla di più concreto dei nostri pensieri i quali influenzano sia il nostro quotidiano che il funzionamento del nostro corpo. Allo stesso tempo, come si fa ad escludere il corpo se anche la mente è corpo? In base alle considerazioni fatte, potremmo chiederci: come può esistere un ambulatorio di cardiologia senza uno psicoterapeuta? Un servizio di medicina di base senza uno psicologo di base? In generale, come è solo pensabile avere ospedali e reparti senza la figura dello psicoterapeuta? L’esperienza professionale ci insegna che nei casi in cui si riesce ad attivare una collaborazione costruttiva tra i diversi professionisti gli obiettivi raggiunti sono nettamente superiori e soddisfacenti se paragonati a quelle situazioni frammentate e scisse, dove si lavora in modo isolato e paranoico, pronti a svalutare e dubitare costantemente sull’utilità e l’importanza delle altre professionalità. L’unico modo per rimettere al centro del nostro interesse il benessere del paziente è quello di superare i propri egoismi e partire dal presupposto che tutte le professioni hanno la loro professionalità, non si possono costruire ordini gerarchici in quanto “nessuno è più importante dell’altro” poiché siamo tutti strettamente interconnessi tra di noi: se tutte le parti non funzionano come dovrebbe, allora i risultati saranno scadenti a prescindere dal singolo valore, l’organismo ha il suo equilibrio interno.

L’invenzione del mondo virtuale ha rivoluzionato le nostre vite e sembra proseguire, in modo spedito, verso un’evoluzione sempre più strutturata e globale. L’uso del mondo virtuale ha coinvolto diverse generazioni riuscendo ad attrarre a se fasce d’età sempre più estreme, infatti i bambini che vi accedono sono sempre più piccoli e gli adulti sempre più grandi. Tra i diversi elementi del mondo virtuale, quello che fornisce una maggiore attrattiva è caratterizzato dal sottoinsieme dei social. Potremmo chiederci, da dove deriva questo successo? Perchè non si riesce a farne a meno? Il mondo dei social ci consente di fornire, agli altri utenti, un immagine di noi stessi plasmata a nostro piacimento. Possiamo apparire professionali, altamente competenti, realizzati e soddisfatti della nostra vita, belli, felicemente impegnati in una relazione sentimentale, pieni di amore, rispettosi della natura e degli animali, eccetera. Un elemento fondamentale potrebbe essere legato proprio all’uso della parola eccetera, infatti internet non ha limiti, possiamo mostrarci come vogliamo dando libero sfogo alle nostre fantasie ed i nostri ideali. Internet è l’unico luogo dove il condizionale, il dovrebbe, si può trasformare nel tempo presente, nell’essere. Il mondo dei social si trasforma nel luogo del Falso Sè, così come fu teorizzato da Winnicott, ovvero il posto dove si costruisce un’identità che aderisce a degli stereotipi, aspettative sociali o ideali personali che ha una funzione protettrice nei confronti del Vero Sè. Quando il Falso Sè si esprime nel mondo reale, esso è soggetto ai limiti della realtà, si può mentire “fino ad un certo punto”. La realtà non ci permette di spingerci oltre, infatti la presenza reale degli altri ci limita nel nostro tentativo di fornire un immagine non realistica di noi stessi. Un altro limite presente nel mondo reale è il tempo, infatti anche se si riesce ad eludere la comprensione altrui, nella fase conoscitiva iniziale, con il passar del tempo la verità verrà sempre svelata. I limiti della realtà fanno in modo che la forbice, il divario tra il Vero Sè ed il Falso Sè possa essere limitato. Ma cosa succede quando i limiti reali decadono? Questo è il caso del mondo dei social, non esistono limiti sia di contenuto che temporali: con qualche foto, frase ad effetto, titolo acquistato o l’uso di termini inglesi si può mentire su tutto per sempre, fino a quando non ci sarà l’incontro reale. Così facendo, il divario tra il Vero Sè ed il Falso Sè non conosce limiti, può divenire smisurato nel mondo virtuale. Questo potrebbe spiegare la dipendenza ed il successo del mondo dei social, l’occasione è troppo ghiotta: illudersi di essere quello che dovremmo o vorremmo essere. L’investimento, senza limiti, sul Falso Sè ci fa allontanare sempre più dal Vero Sè: a furia di mentire agli altri, mentiamo anche a noi stessi. Con il tempo diveniamo confusi, disorientati e non riusciamo più a distinguere cosa appartiene al Vero Sè ed al Falso Sè. Il Vero Sè può essere coperto, sopraffatto dal Falso Sè però il suo nucleo resterà sempre nella nostra sfera psichica riaffiorando costantemente. Per questo motivo, la presenza del Falso Sè richiede uno sforzo continuo, da parte della persona, che dovrà sostenere le sue “bugie” per evitare che queste possano essere smascherate. In questo modo si crea un circolo vizioso difficile da interrompere: l’emersione di elementi del Vero Sè sono accompagnata dal sostegno al Falso Sè. Questo sembra il circuito dove potrebbe inserirsi la dipendenza dei social, più ci sono eventi reali che ci ricordano le nostre mancanze, aspetti di vite e della nostra persona che ci deludono, più ci ancoriamo al mondo virtuale. L’ancoraggio al mondo virtuale assume, in questi termini, un illusione dove rifugiarci per sfuggire da noi stessi, dal Vero Sè e dalla capacità di accettare i nostri limiti. La fuga nel mondo virtuale crea una grossa frattura interna, una parte di noi sarà sempre ancorata al mondo reale perché non potrebbe essere altrimenti, noi viviamo nel mondo. Inoltre, anche il mondo virtuale ha un piede in quello reale, poggia le sue basi sul mondo. Poi ci sono altre parti di noi, appartenenti al Falso Sè, che cercano di restare separate, scisse dal resto della nostra persona rimanendo confinate nel mondo virtuale. Ma cosa accade quando, per qualche motivo, questa scissione non può più essere sostenuta? Gli scenari non possono che essere tragici, pensiamo al suicidio o allo scompenso, poiché la psiche della persona non ha mai elaborato elementi di realtà che crollano tutti insieme, contemporaneamente. Il soggetto si ritrova, improvvisamente, a dover fare i conti con contenuti del mondo reale che sono stati rigettati e negati, con tutte le proprie forze, generando una grossa quota di angoscia. L’individuo si potrebbe percepire perso, senza via di scampo e sopraffatto da un troppo, da un eccesso in base a quelle che sono le sue risorse psichiche. Il rinnegamento e l’incapacità di accettazione della realtà, in tutte le sue sfumature, sembra essere il motivo della dipendenza dal mondo virtuale, la ragione per cui le persone prediligono l’incontro virtuale a quello reale. I rapporti virtuali vengono presentati come “semplici e di moda”, pensiamo agli adolescenti che cercano i contatti social dei pari per conoscersi, ma cosa si intende con l’uso di questi termini? La semplicità potrebbe essere sinonimo di finzione, ovvero il conoscersi tramite il mondo virtuale ci permette di presentare la nostra maschera all’altro senza rischiare di essere smascherati. La paura di mostrare, fin dall’inizio, se stessi, il Vero Sè con il timore di essere rifiutati viene nascosta con argomentazioni superficiali e l’uso di frasi stereotipate. La scelta della conoscenza tramite i social viene giustificata come “la moda del momento, fanno tutti così”. Allora potremmo chiederci, perché tutti si sono allineati a questa modalità? Il motivo sembra risiedere nella sua utilità, infatti il mondo virtuale ci permette di nascondere le nostre paure ed insicurezze. Voler essere come dovremmo o vorremmo essere equivale a non accettarsi, altrimenti perché fingere? Se il Vero Sè non può emergere chiaramente, ma deve essere coperto e protetto dal Falso Sè è per via della sua fragilità ed inadeguatezza.
Chiama il dottor Cassese per fissare un appuntamento